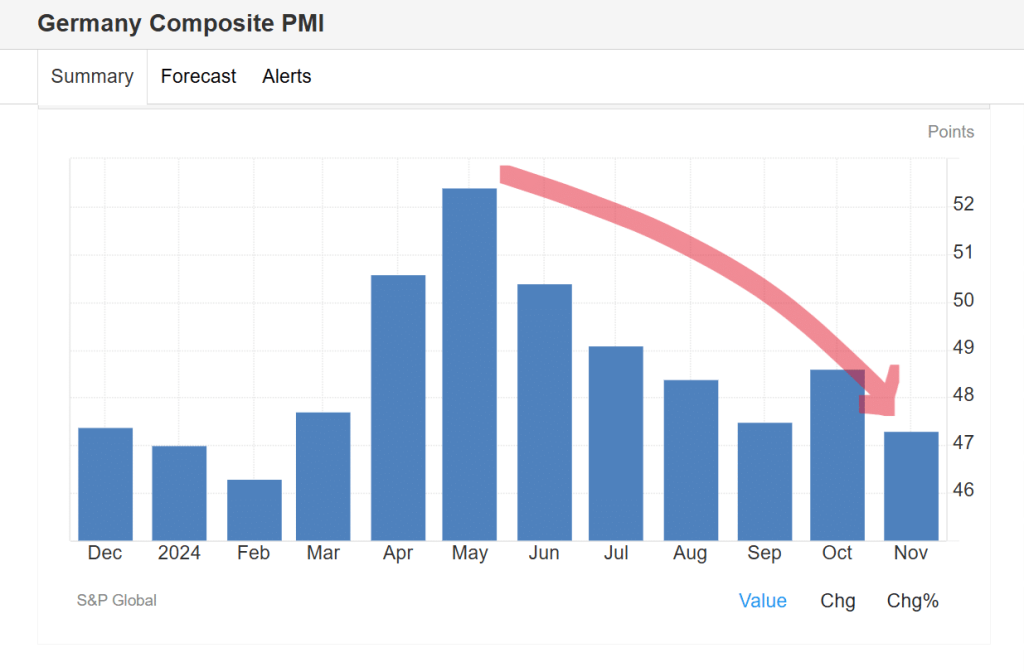Erano i primi giorni di gennaio, quando la rete impazzava dietro a una notizia apparentemente rivoluzionaria: la Finlandia introdurrà la settimana di lavoro corta, cioè di 4 giorni per 6 ore al giorno e a parità di stipendio. La speranza era stata accesa da un discorso pronunciato dalla neo-premier Sanna Marin, la donna più giovane della storia a capo di un governo nel mondo a soli 34 anni. Dopo qualche giorno, la smentita dell’esecutivo affidata ai social: “Nel programma del governo finlandese non c’è alcun riferimento alla settimana da 4 giorni.
In una sola dichiarazione, lo spegnimento delle speranze di quanti nel mondo avevano guardato a Helsinki come prossimo passo sulla strada della rivoluzione del lavoro. Del resto, sembrava troppo bello per essere vero. Certo, i precedenti non mancherebbero. Nel 1997, il ministro del Lavoro francese, Martine Aubry, si batté per introdurre la settimana lavorativa di 35 ore. Affinché l’esperimento non naufragasse per l’impossibilità delle imprese di sostenere l’aumento dei costi (si produce meno e si paga uguale, per cui il costo unitario cresce), esso fu annacquato per renderlo sostanzialmente compatibile con la realtà occupazionale ed economica transalpina.
L’idea di lavorare meno e a parità di stipendio affascina e crea dibattito. I sostenitori ritengono che ciò aumenti sia il benessere dei lavoratori che la crescita dell’economia, perché i primi avrebbero più tempo per prendersi cura di sé e delle loro famiglie, si sentirebbero meglio e al lavoro renderebbero di più. Inoltre, disporrebbero di più tempo per andare in giro, godersi la vita e consumare, alimentando la crescita del pil. I detrattori oppongono un ragionamento elementare, quanto incontrovertibile: aumentare il costo unitario di produzione si ripercuote sui prezzi, deprimendo il potere di acquisto degli stessi lavoratori, costretti a spendere di più per acquistare gli stessi beni e servizi.
Ha senso l’orario di lavoro?
Strano questo Occidente, dove ci si appiglia alla minima cifra che rilevi un aumento della disoccupazione su questo o quel mercato e il tasso dei lavoratori part-time viene guardato sempre con estremo sospetto, ma in cui sembra che si faccia di tutto per ridurre ai minimi termini l’orario di lavoro. A sinistra, vi sarebbero pochi dubbi: lavorare meno, lavorare tutti. Peccato che non funzioni esattamente così, per quanto sinteticamente sopra accennato. Vero è che nella storia che va dalla Rivoluzione Industriale ad oggi, il legislatore sia intervenuto più volte per porre limitazioni all’orario di lavoro massimo, ma questo è avvenuto a seguito delle migliorate condizioni economiche, le quali hanno consentito alle imprese di recepire senza traumi quanto già fosse nelle loro possibilità.
Salvo rare eccezioni, oggi il contratto di lavoro standard nel mondo avanzato è di 40 ore alla settimana, perlopiù spalmato in 5 giornate da 8 ore ciascuna. Ha senso che nel 2020 continui ad essere un riferimento per imprese e sindacati? Dipende. Alcuni comparti già da tempo si mostrano abbastanza flessibili, perché il timbro del cartellino per loro assume scarso significato. Parliamo dei servizi, di tutta quella sfera di attività dalla produzione non immediatamente misurabile o, comunque, non dipendente in maniera puntuale dalle ore lavorate. Pensate che sia più redditizio per un’azienda commerciale un agente che gira in lungo e in largo la propria area di competenza per 8 ore al giorno senza concludere un contratto di vendita o uno che, pur impiegandoci molto meno tempo, riesce a fatturare per la maggiore capacità di procurarsi contatti giusti e di vendere il prodotto?
L’orario di lavoro è sempre meno incisivo ai fini della produzione, così come sempre meno osservabile, se non indirettamente.