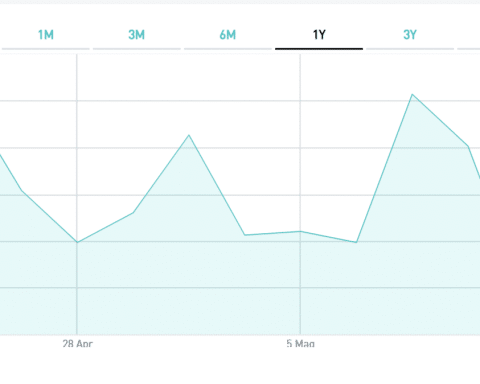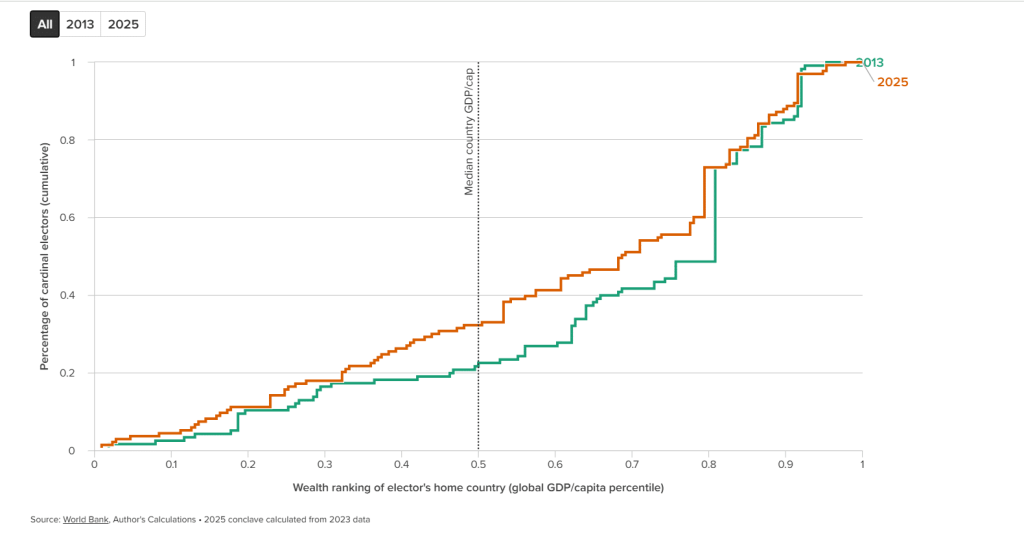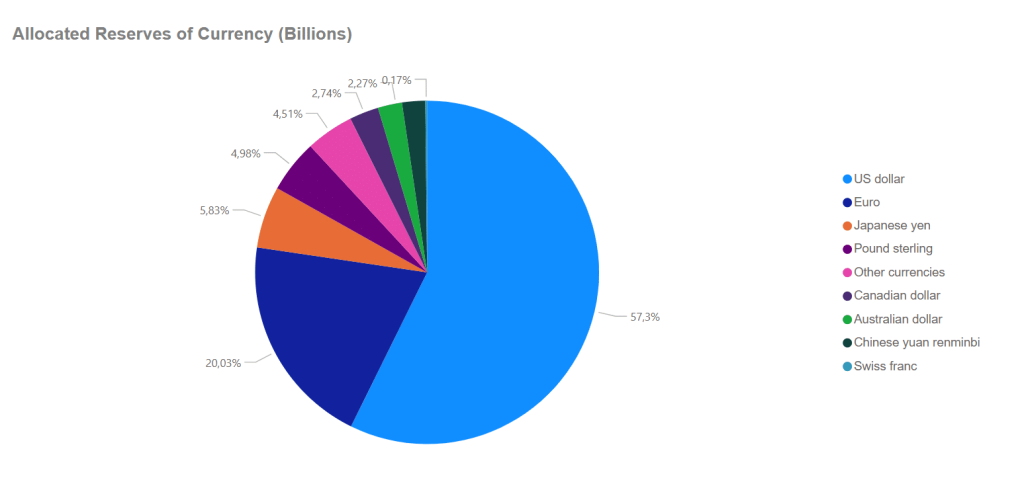Che ne sarà dei lavoratori italiani dopo quota 100? E il governo Draghi metterà mano a una riforma delle pensioni che, preservando la sostenibilità della previdenza, garantisca al contempo maggiore flessibilità in uscita ai lavoratori? E i dipendenti pubblici potranno davvero lasciare il posto ai più giovani a partire dai 62 anni di età, grazie al super-scivolo di 5 anni ipotizzato dal ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta?
Gli interrogativi sulla possibile prossima riforma delle pensioni in Italia si moltiplicano. Il tema è scottante un po’ in tutto l’Occidente. Basti guardare alle imponenti manifestazioni di piazza in Francia. Lì, prima dell’emergenza Covid il presidente Emmanuel Macron dovette rinunciare alla madre di tutte le riforme promesse, a causa della fortissima opposizione delle categorie.
Il modello cileno per la riforma delle pensioni
Eppure, esiste un modello di successo e non si trova né in Europa e né nel Nord America. Parliamo del Cile di Augusto Pinochet. Era il 1981 e l’economista José Pinera, fratello dell’attuale presidente Sebastian, ispirò una riforma delle pensioni dall’esito clamorosamente positivo. Il sistema previdenziale a fine anni Settanta annegava in un mare di debiti. Il suo disavanzo ammontava al 3% del PIL e veniva stimato al 20% del PIL entro il 2000. Fu allora che il governo diede vita al passaggio da un sistema a ripartizione a un sistema a capitalizzazione.
Fino a quel momento, i lavoratori cileni versavano i contributi all’ente previdenziale dello stato. E questo li usava per pagare gli assegni ai pensionati di quel momento. Esattamente quello che accade in Italia e in quasi tutto il mondo. Con la riforma delle pensioni, si diede la libertà ai lavoratori di scegliere se aderire a un fondo previdenziale privato o se restare in quello pubblico.
In ogni caso, i versamenti sarebbero stati investiti per pagare le pensioni future agli iscritti. Un cambio di paradigma estremamente importante: i contributi non servono più per pagare gli assegni ai pensionati del momento, bensì a sé stessi quando si andrà in pensione.
Il 99% dei lavoratori cileni risulta aderire a un fondo privato. E il rendimento medio nei decenni è stato dell’8,3%. Al confronto, le rivalutazioni annue dell’INPS appaiono bazzecole. Ma c’è un però, anzi più di uno: ciascuno percepisce un assegno in linea a quanto versato, così come accade quando ci si iscrive a un fondo privato. Se verso poco, perché ho uno stipendio basso o lavoro in maniera discontinua, rischio di avere una pensione altrettanto bassa. Tuttavia, nel modello cileno lo stato garantisce a tutti i cittadini un assegno minimo. Inoltre, di recente il governo ha chiesto ai datori di compartecipare alla contribuzione con versamenti per il 4% dello stipendio lordo.
La transizione impossibile
Ma il vero problema (insormontabile) è un altro: se i contributi che verso sono investiti per la mia pensione futura, chi paga i pensionati di oggi? In effetti, anche il Cile si trovò ad affrontare questo dilemma. Con la riforma delle pensioni, le casse previdenziali pubbliche si svuotarono e lo stato dovette attingere alla fiscalità generale fino al 7% del PIL per pagare gli assegni.
Ancora oggi, il suo impatto viene stimato nell’ordine di qualche punto di PIL fino ad azzerarsi dopo il 2030.
Se l’Italia dovesse adottare il modello cileno, avrebbe due strade davanti a sé: obbligare i lavoratori e le imprese a versare il doppio dei contributi (una volta per pagare le pensioni odierne, un’altra per pagare le pensioni proprie future) o gravare sulla fiscalità generale. In questo secondo caso, bisognerebbe o alzare le tasse o tagliare i servizi o finanziare la misura in deficit o fare un po’ di tutte queste tre cose. Il problema è che non stiamo parlando di qualche punto di PIL. La spesa per le pensioni assorbe circa il 16% del PIL, per cui sarebbe impossibile anche solo immaginare di battere ciascuna delle suddette strade. E a maggior ragione, con un debito pubblico già al 160% del PIL e una pressione fiscale ai limiti della sopportazione per i contribuenti.
Certo, se fosse possibile importare il modello cileno, non dovremmo più preoccuparci delle dinamiche demografiche. Che nascano pochi bambini o meno, i futuri pensionati si saranno già pagati la pensione da soli. Purtroppo, la riforma delle pensioni necessaria per tendere a questa condizione appare irrealizzabile. Avremmo dovuto pensarci almeno mezzo secolo fa, quando la demografia e i dati macro ci avrebbero consentito di affrontare la transizione.
giuseppe.timpone@investireoggi.it