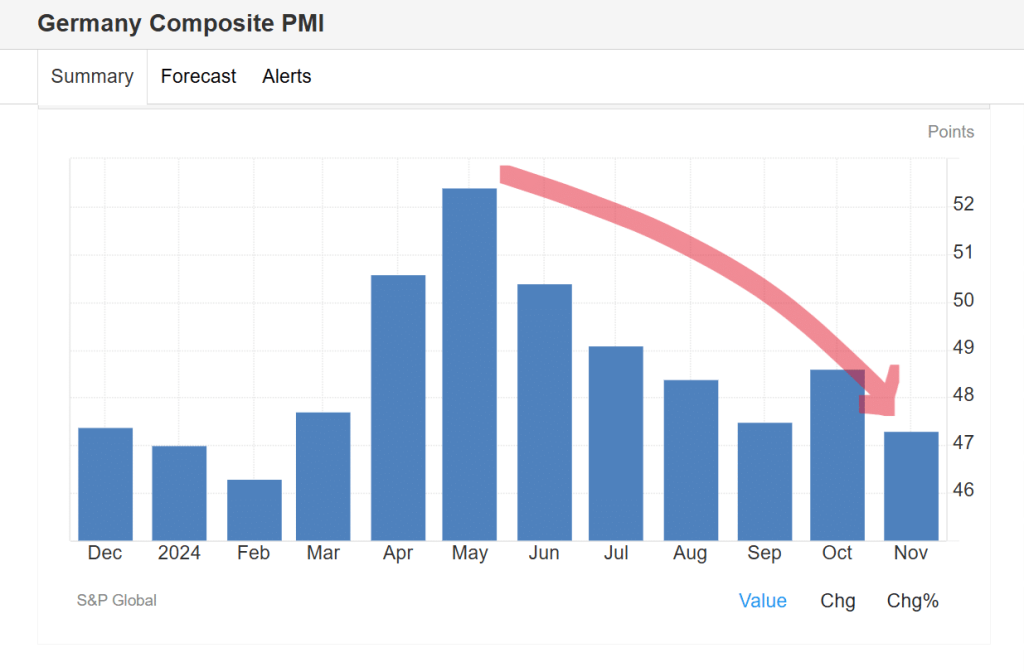La relazione Covip (Commissione di Vigilanza sui fondi pensione) ha confermato che anche nel 2020 i fondi pensione hanno battuto mediamente il TFR sul piano del rendimento. I fondi negoziali hanno registrato una crescita del 3,1%, i fondi aperti del 2,9%. Nello stesso anno, invece, gli accantonamenti al Trattamento di Fine Rapporto sono stati rivalutati solamente dell’1,2%.
I dati Covip ci offrono spunti interessanti per avere una proiezione oggi del futuro della previdenza italiana. Anzitutto, ci dice che le masse gestite sono state di 198 miliardi, a cui si aggiungono 96 miliardi delle casse di previdenza.
Ma esistono grosse differenze. Anzitutto, tra sessi: gli uomini rappresentano il 61,7% delle iscrizioni, le donne il restante 38,3%. E tra nord e sud: gli iscritti sono per il 57% del Settentrione. Infine, tra generazioni: il 51,6% ha un’età compresa tra 35 e 55 anni, il 31% è over 55 e solamente il 22,7% ha meno di 35 anni. Combinando questi dati con quelli OCSE, troviamo conferma che la previdenza complementare in Italia non sia affatto sviluppata. Secondo l’organismo con sede a Parigi, nel 2019 gli asset dei fondi pensione in Italia ammontavano solamente all’8,4% del PIL. Meglio del 7,5% della Germania, per non parlare dello 0,8% della Francia. Ma molto, molto meno del 194,4% dell’Olanda, del 143,7% della Svizzera o del 108,7% del Regno Unito.
Fondi pensione, disparità accentuate in vecchiaia
Le principali tre economie dell’Eurozona e della UE, quindi, continuano a fare affidamento sulla previdenza pubblica. Per convinzione o, in moltissimi casi, per necessità. Sì, perché i versamenti a favore di fondi pensione privati diventano molto difficili in sistemi con elevata contribuzione pubblica. In Italia, un terzo dello stipendio lordo di un lavoratore dipendente se ne va nelle casse dell’INPS.
E questo discorso vale a maggior ragione per giovani, donne e meridionali, cioè le fasce della società italiana più in difficoltà e che avrebbero tutto il vantaggio ad aderire a una qualche forma di previdenza complementare per sfuggire almeno durante la vecchiaia al rischio di povertà. Ma tra stipendi molto bassi e contratti precari, difficile che riescano a mettere da parte qualcosa per la terza età. E così, le differenze intergenerazionali, tra sessi e tra nord e sud potrebbero finire per accentuarsi nei prossimi decenni, quando i lavoratori di oggi andranno in pensione. Chi avrà potuto versare contributi a un fondo pensione, riuscirà a mantenere livelli di reddito ben maggiori di quanti dovranno affidarsi solamente alla pensione pubblica. Per quanto ancora relativamente generosa nel confronto internazionale, questa è attesa ben inferiore a quella odierna in rapporto all’ultimo stipendio percepito.
Inutile invocare un cambio di mentalità, quando ciò che serve sono condizioni socioeconomiche differenti. E’ la rivoluzione fiscale la molla che potrebbe cambiare lo scenario. Come? Abbattendo l’imposizione sui redditi medi e sgravando il più possibile i rendimenti maturati sul capitale accantonato in un fondo pensione. Infine, anche le stesse rendite andrebbero defiscalizzate. Bisogna offrire una prospettiva quanto più favorevole per il risparmio investito a favore della vecchiaia. A chi gridasse che si tratterebbe di una misura fiscale regressiva, occorrerebbe ribattere che solamente attraverso la leva fiscale la dipendenza dei lavoratori verso l’INPS si allenterebbe. E ciò renderebbe anche meno complicato in futuro adottare nuove riforme delle pensioni e affrontare le sfide poste dalla demografia.