Tutti a parlare di crisi dell’America, poi si guardano i numeri e si legge una realtà apparentemente ben differente. Con un Pil pro-capite sopra 87.000 dollari e un tasso di disoccupazione che continua ad oscillare attorno al 4%, tutto diremmo fuorché si tratti di un’economia in panne. Ma anche l’ultima campagna elettorale che ha portato alla vittoria di Donald Trump ha confermato il forte malcontento che cova da molti anni entro i confini della superpotenza.
America in crisi dopo apparente boom
Basterebbe un raffronto per smentire il pessimismo. Tra il 2008 e il 2024 l’economia nell’Unione Europea è cresciuta solamente del 19% e nell’Area Euro meno del 26%. Negli Stati Uniti del 39%. Il 2008 non è stato preso come anno a caso. Fu quando collassò il mercato dei mutui subprime. Ne scaturì una potente crisi finanziaria globale. Si disse allora che l’America fosse caduta in una crisi esistenziale e capace possibilmente di segnarne la battuta d’arresto in via definitiva. Accadde il contrario, in apparenza. Uscì veloce e forte da quell’evento così drammatico, mentre l’UE entrava in una fase di convulsioni economiche, sociali e politiche.
La Brexit nel 2016 ne decretava il fallimento progettuale.
Crescita Pil a debito
Ma i numeri vanno interpretati e letti nel loro insieme. Approfondendo, scopriamo che la maggiore crescita degli USA sull’UE è stata più che giustificata da un aumento relativamente più alto del debito pubblico. In effetti, nell’UE è passato dal 65% all’81% del Pil, mentre negli USA è esploso dal 73% al 123%. Dunque, sono serviti 50 punti di debito in più per ottenere una crescita del 39% per il Pil. Nell’UE sono bastati 16 punti di debito per 19 punti di crescita.
Nell’Area Euro il rapporto debito/Pil è salito del 18% contro una crescita economica di neanche il 16%.
In parole povere, il “successo” dell’economia americana è avvenuto a colpi di debito pubblico. E la realtà è ben diversa anche per quanto riguarda il lavoro. Ci sono pochi disoccupati negli USA, ma anche l’occupazione è bassa. Appena del 60% contro una media europea superiore al 70%. Persino l’Italia vanta ormai un tasso al 63% e sappiamo quanti posti di lavoro manchino in alcune aree del Paese. Ad occhio e croce, sarebbe come ammettere implicitamente che, nel confronto con l’UE, manchino agli americani una trentina di milioni di posti di lavoro.
Finanza e governo a braccetto
Cos’è successo? La crisi dell’America parte da lontano, ovvero da quando la finanza ha prevalso sulle stesse istituzioni, svuotando il capitalismo di significato. La patria del libero mercato è cresciuta per secoli nel mito del “self made man”, della libera iniziativa, dello stato che incoraggia il successo, del fallimento come esito accettabile e non giudicabile secondo criteri moralistici. Dagli anni Novanta in avanti, però, Wall Street ha capito che può contare sul governo in caso di bisogno. Con Alan Greenspan alla guida della Federal Reserve (1987-2006) si crea un rapporto incestuoso tra banca centrale e finanza.
Il primo corre in soccorso della seconda ogni volta che serve a rianimare gli indici azionari.
Fu il famoso “Greenspan put” e consistette nel tagliare i tassi di interesse per aumentare la liquidità sui mercati e favorire una veloce ripresa dei corsi. La finanza si percepì onnipotente. Che bisogno c’era di mostrarsi prudente, quando poteva sempre bussare alla porta della FED e ottenere aiuto? Fu così che si arrivò alla crac di Lehman Brothers del 2008. Negli anni precedenti, i tassi erano stati abbassati fino all’1% e le banche concedevano i mutui praticamente a chiunque, pur di impiegare la liquidità in qualche modo. Quando risalirono per contrastare l’inflazione, molti clienti smisero di pagare le rate e mandarono l’America in crisi.
Malcontento diffuso dopo 2008
Questa commistione tra finanza e politica portò a una grande rabbia popolare. I cittadini percepirono di dover pagare il costo di decisioni prese da altri e non nel loro interesse. I salvataggi bancari diffusero la sensazione che il capitalismo per Wall Street fosse un sistema per fare profitti in tempi di vacche grasse e socializzare le perdite in tempi di vacche magre. La reazione della FED non solo non mutò di una virgola rispetto ai decenni passati, ma anzi divenne ancora più estrema: tassi a zero e maxi-iniezioni di liquidità sui mercati. I finanzieri ebbero montagne di denaro da investire per acquistare asset a basso prezzo e rivenderli a prezzi stellari. I già ricchi accrebbero enormemente i patrimoni. La concentrazione della ricchezza fu vistosa e senza alcuna giustificazione di sorta basata sul merito.
Cosa c’entra tutto questo con la crisi dell’America di oggi? I governi che si sono succeduti negli ultimi decenni, da Barack Obama a Trump passando per Joe Biden, hanno tutti compreso l’impossibilità di tirare troppo la corda. Hanno cercato a modo loro di accontentare l’elettorato, vuoi alzando la spesa pubblica, vuoi tagliando le tasse. Tutto in deficit. In questo modo, hanno comprato tempo nella speranza che le cose si sarebbero aggiustate da sole. L’economia è cresciuta meglio che nel resto dell’Occidente, ma i debiti sono cresciuti di più.
E adesso presentano il conto.
Crisi America, servono azioni lungimiranti
Nel 2024 il Pil è salito del 2,9% e il deficit è stato del 6,7%, cioè di 2.000 miliardi. Cifre non più sostenibili e che richiedono azioni coraggiose e lungimiranti da parte del governo federale. Da cui i tagli alla spesa del DOGE (Elon Musk) e i dazi annunciati dalla Casa Bianca per cercare di invertire la rotta. Sono azioni estreme, che servono anche a segnalare all’opinione pubblica una cesura con il passato. I tagli alla spesa servono senza dubbio, mentre i dazi appaiono un harakiri. Comunque la si pensi, la conferma che la crisi dell’America non è un’invenzione giornalistica ed è stata a lungo ben camuffata da numeri sulla crescita apparentemente invidiabili.
giuseppe.timpone@investireoggi.it
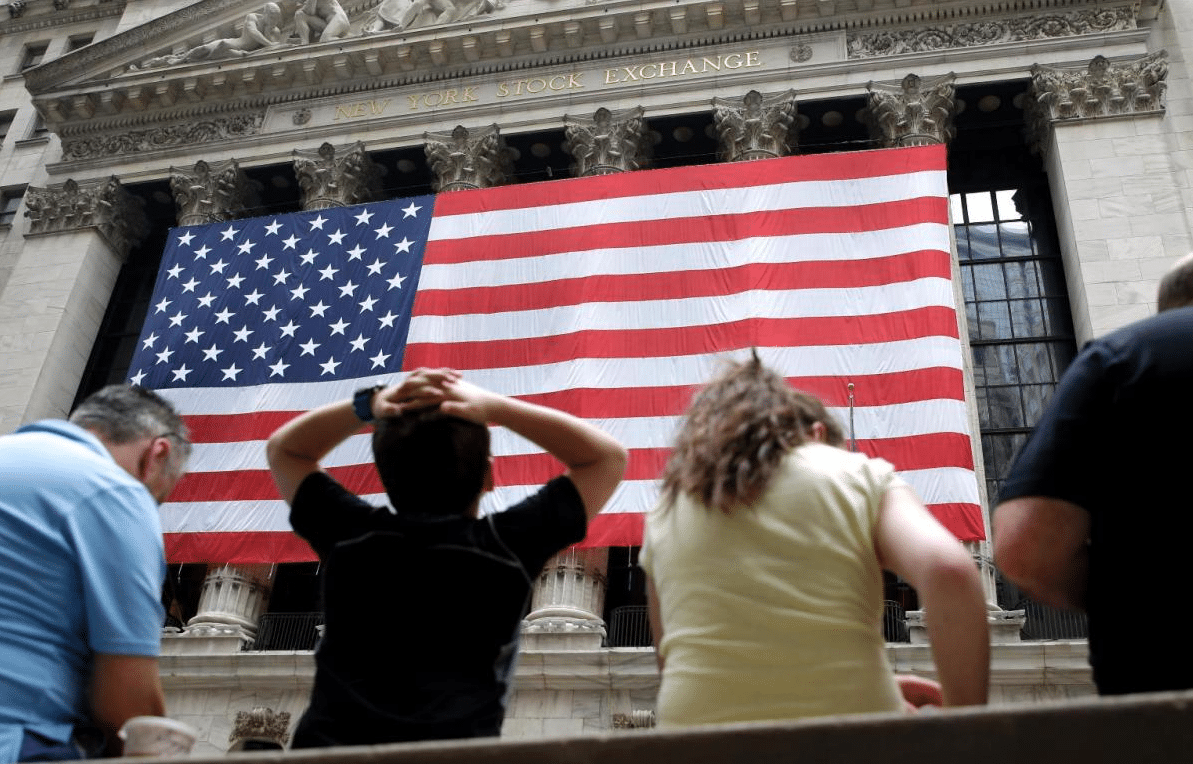

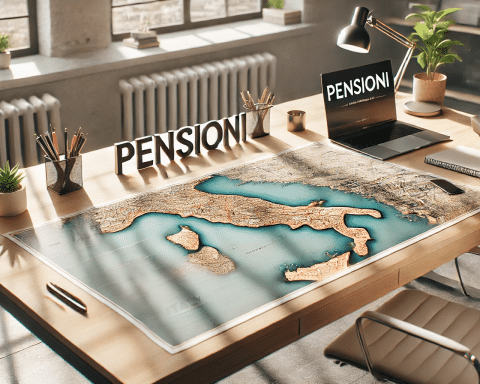








Articolo molto interessante che nel sintetizzare molto bene quanto avvenuto in questi anni disvela anche la grande fragilità di questo colosso i cui piedi ora sono d’argilla.