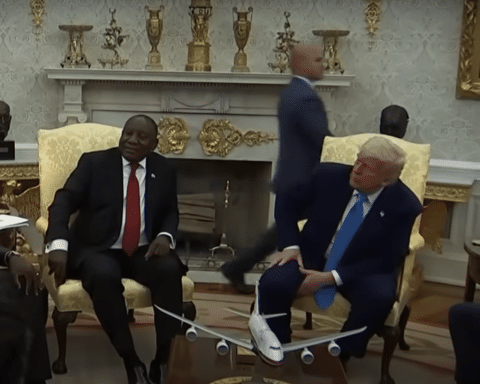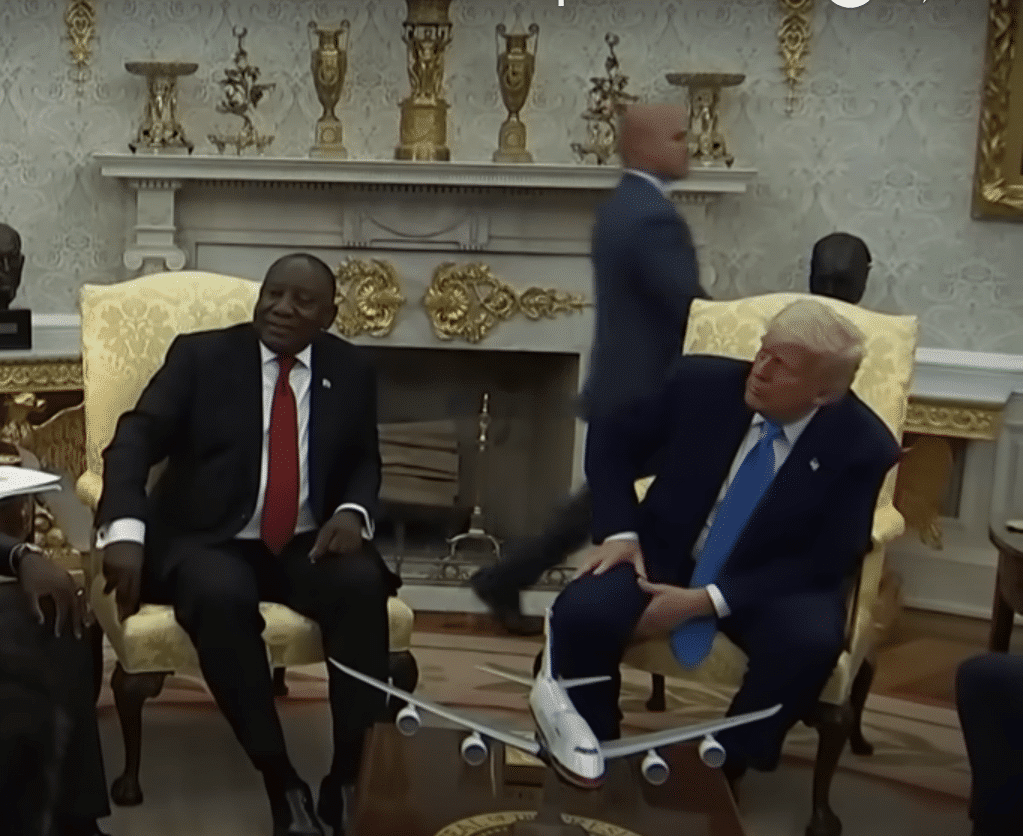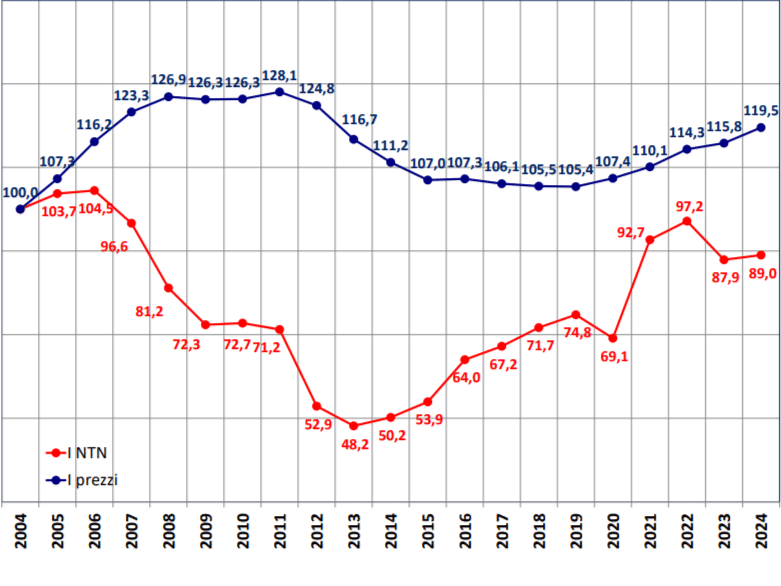Quando oltre un anno fa iniziò la crisi delle quotazioni del petrolio, molti analisti la inquadrarono come il tentativo dell’Arabia Saudita di porre fine a un lustro fin troppo positivo per l’industria energetica americana, la quale con lo sfruttamento dello “shale” ha aumentato in questi anni notevolmente la sua produzione, annullando le importazioni nette da Riad e diventando il terzo produttore mondiale. Secondo i dati dell’EIA (“Energy International Agency”), gli USA hanno contributo per 1,6 milioni di barili al giorno nel 2014 all’aumento dell’offerta di greggio sul mercato mondiale, 5 volte in più dell’Iraq. Naturale che il Regno Saudita abbia voluto ostacolare i piani americani, che rischierebbero altrimenti di scalfire il suo primato.
Tuttavia, a un anno di distanza, non possiamo affermare che i sauditi ce la stiano facendo. Le compagnie petrolifere americane hanno tagliato gli investimenti per centinaia di miliardi e ridotto di oltre la metà il numero dei pozzi attivi, ma la loro produzione è ancora quasi ai livelli massimi toccati a metà anno. Al contrario, la Russia ha aumentato le sue estrazioni per contrastare gli effetti del calo dei prezzi, superando l’Arabia Saudita con riguardo alle esportazioni di greggio verso la Cina sin dal maggio scorso. In particolare, Mosca ha inviato a Pechino 3,92 milioni di tonnellate di greggio nel mese, mentre Riad 3,05 milioni. Si calcola che i principali 7 clienti asiatici assorbano più della metà delle esportazioni saudite, ovvero 4,4 milioni di barili al giorno. Resta il fatto che la quota di mercato in Asia si sia ridotta al 23,2%, meno di un quarto. Nei giorni scorsi, l’FMI ha suonato l’allarme per l’intero Medio Oriente, stimando in mille miliardi di dollari le perdite che i paesi produttori di petrolio subirebbero in 5 anni.
E l’Arabia Saudita potrebbero esaurire le sue riserve valutarie in un lustro, a questi ritmi. Solo quest’anno, ha calcolato il Tesoro USA, si registrerà uno spostamento di reddito per 600 miliardi di dollari verso le economie importatrici.