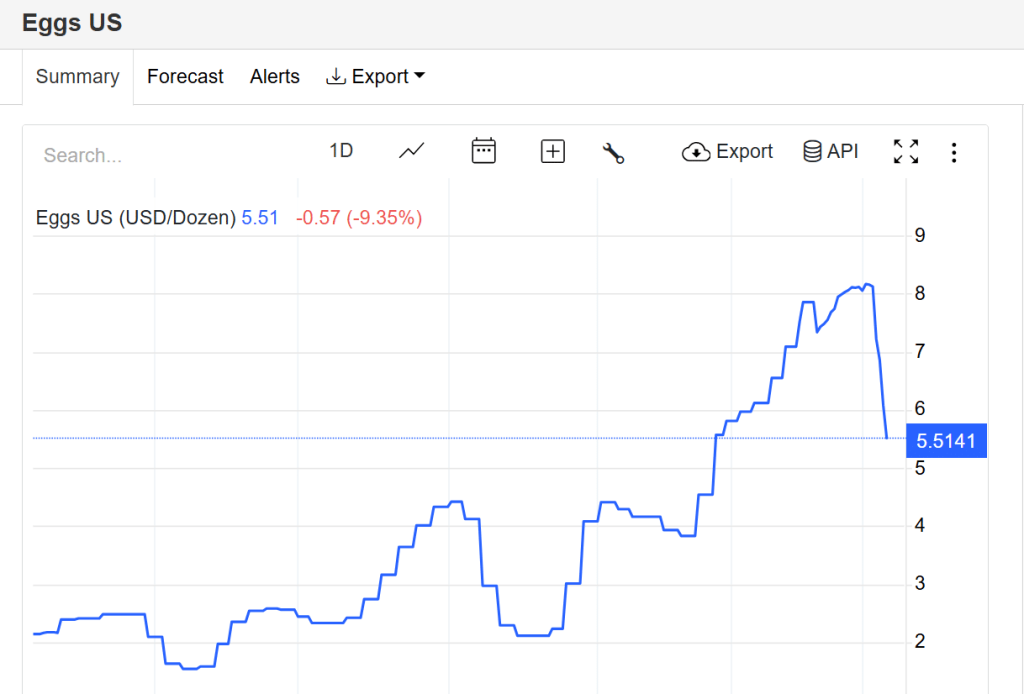L’approvazione della legge sulla sicurezza con cui la Cina limita l’autonomia di Hong Kong ha mandato su tutte le furie gli USA, che hanno chiesto invano a Pechino di attenersi agli accordi internazionali sottoscritti prima che la regione passasse sotto il suo controllo, quando ancora era un protettorato britannico. Una delle opzioni a cui il presidente Donald Trump vorrebbe ricorrere sarebbe di porre fine al “peg”, il tasso di cambio semi-fisso con cui dal 1983 il dollaro di Hong Kong è agganciato a quello americano attorno al valore di 7,80.
Perché i bond di Hong Kong sono diventati più rischiosi di quanto dicano i rating
La regione ha adottato un sistema monetario, noto in economia come “currency board”: la quantità di moneta locale stampata è legata alle riserve valutarie disponibili e non può eccederle.
Ad oggi, Hong Kong detiene riserve valutarie per oltre 440 miliardi di dollari, oltre il doppio rispetto alla moneta in circolazione e pari a quasi il 120% del pil. Cosa accadrebbe se la Casa Bianca decidesse di porre fine al peg e, soprattutto, come potrebbe provocarne la fine?
In teoria, l’opzione in mano agli USA sarebbe di impedire alle banche cinesi di accedere ai dollari americani, una misura estrema e che avrebbe come immediata conseguenza l’esplosione di tensioni finanziarie non solo a Pechino, ma presumibilmente in tutto il mondo. In effetti, le sanzioni limiterebbero la capacità di rifinanziamento di stato, società e banche cinesi sui mercati, alzandone i costi e provocando contraccolpi economici e persino commerciali.
Cambio finora al riparo dalle tensioni
Un simile scenario sarebbe rischioso per Trump alla vigilia delle elezioni presidenziali, che già sono tese di loro tra Coronavirus, proteste anti-razzismo e crisi dell’economia.
Non è da escludere, però, che il tycoon si giochi proprio la carta cinese per mostrarsi più duro con la controparte e protettore degli interessi americani rispetto allo sfidante democratico Joe Biden. Gli effetti di simili restrizioni, tuttavia, non sarebbero immediati. Le abbondanti riserve valutarie di Hong Kong rasserenerebbero gli animi tra gli investitori, dissuadendoli dal fuggire dalla città-stato, anche perché la stessa Cina detiene riserve cospicue e pari a ben 3.000 miliardi di dollari, capaci di coprire nel breve e medio periodo eventuali deflussi finanziari.
La mano cinese su Hong Kong è il primo atto della “guerra” commerciale post-Coronavirus
Non si respira ad oggi aria di panico, tant’è che la banca centrale di Hong Kong ha venduto giovedì scorso 13,4 miliardi di dollari locali per acquistare 1,7 miliardi di dollari USA, al fine di mitigare le pressioni al rialzo sui tassi di cambio. E questi si attestavano ieri a 7,75, cioè al limite più basso del range consentito, segno che al momento il problema del territorio sarebbe di tenere a freno gli afflussi dei capitali, l’esatto contrario di quanto ci saremmo aspettati in questa fase di forti tensioni internazionali e tra la stessa popolazione di Hong Kong e la Cina.
Del resto, i tassi d’interesse qui risultano fissati allo 0,50%, che per quanto bassi si rivelano pur sempre nettamente superiori ai livelli azzerati della Federal Reserve. E anche per questa via, il Monetary Authority riesce ad attirare capitali. Peraltro, da quando la legge è stata presentata al Congresso del Popolo e successivamente votata, l’indice azionario Hang Seng ha consolidato i guadagni, anche perché il suo valore per i tre quarti si deve alle società cinesi quotate.
La reazione dei mercati
La fine del peg non sarebbe immediata, anche se il governo americano la perseguisse come obiettivo esplicito. Ma la minaccia non va nemmeno sottovalutata, tant’è che forse anche l’apprezzamento di oro, argento e Treasuries nelle ultime sedute può avere un po’ a che vedere con tali tensioni. Il metallo si è portato ai massimi da 9 anni, sfondando in settimana la soglia dei 1.800 dollari l’oncia. L’argento non è stato da meno, fiutando anche il recupero della produzione industriale nel mondo e puntando a 20 dollari, ripiegando in area 18,70 nella seduta di venerdì. Infine, i rendimenti americani sono scesi su alcune scadenze ai minimi storici, attestandosi allo 0,26% sul tratto quinquennale e allo 0,58% su quello a 10 anni.
Hong Kong è solo uno dei tanti casi di tensioni internazionali che agitano gli animi degli investitori, ma non figura tra quelli meno temuti. La sua autonomia sminuita da Pechino è diventata l’emblema dello scontro tra Occidente e Cina, con il primo guidato dagli USA, intenzionati a sfruttare l’occasione per rimescolare le carte della globalizzazione, dando vita a un imponente “reshoring” ai danni dell’economia asiatica. E in piena campagna elettorale tutto può succedere, anche che Trump sganci una qualche “bomba” su Pechino per scombinare i giochi.
Hong Kong è una bomba da 35.000 miliardi e sta per scoppiare