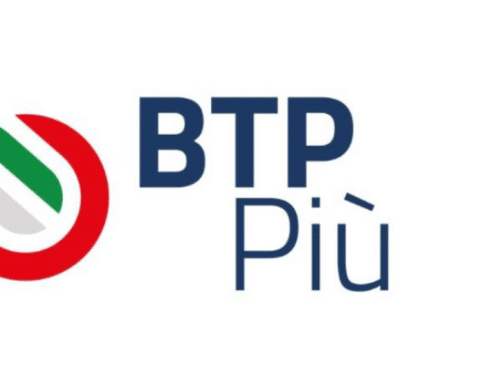Il governatore di Hong Kong, Carrie Lam, ha avvertito gli USA che nel caso in cui ponessero fine allo US-Hong Kong Policy Act del 1992, le conseguenze non sarebbero negative solo per l’economia del territorio autonomo, ma anche per le imprese americane, di cui 1.300 hanno sede proprio qui. Proprio in queste ore, il presidente Donald Trump dovrebbe annunciare la sua risposta alla Cina, il cui Congresso Nazionale del Popolo ha approvato una legge sulla sicurezza, che nei fatti assoggetta Hong Kong alle autorità centrali di Pechino, riducendo quei margini di autonomia di cui ha potuto godere grazie alla politica di “uno stato, due sistemi”, perseguita dall’allora presidente Deng Xiaoping sin dagli anni Ottanta, in vista della consegna della colonia nel 1997 da parte del Regno Unito.
La mano cinese su Hong Kong è il primo atto della “guerra” commerciale post-Coronavirus
Hong Kong è diventata in questi ultimi decenni una importantissima piazza finanziaria mondiale, la quarta più grande e un vero hub per i capitali. Pur facendo parte formalmente della Cina, la sua autonomia è stata preservata senza interferenze da parte di Pechino fino allo scorso anno, garantendo agli investitori stranieri mani libere. Il risultato è stato un pil che oggi tocca i 50.000 euro pro-capite, circa 5 volte superiore a quello della madrepatria.
La Borsa di Hong Kong valeva al 30 aprile scorso 35.000 miliardi di dollari, pur in calo del 20% quest’anno, grazie alle sue 2.477 società quotate. Non esiste grande società cinese che non scelga di quotarsi qui, tra cui Alibaba, il colosso delle vendite online. Massima libertà è stata finora garantita al territorio anche sul piano commerciale, grazie all’accordo con gli USA di inizio anni Novanta, tant’è che gli scambi con l’estero sono sganciati da quelli con la Cina, sottoposti a una legislazione differente.
In effetti, la “guerra” dei dazi degli ultimi due anni ha risparmiato Hong Kong, con cui l’America matura annualmente un surplus commerciale nell’ordine di oltre 30 miliardi di dollari e cumulativamente nel periodo 2009-2018 pari a 297 miliardi.
Fine dello status di Hong Kong
Ma adesso, tutto sta per cambiare. Il governo cinese non intende più tollerare quegli spazi di autonomia sinora garantiti e già nel corso del 2019 aveva cercato di far passare una legge per l’estradizione, che nei fatti avrebbe sottoposto gli abitanti di Hong Kong al rischio di ritrovarsi giudicati e condannati in un tribunale cinese. Dopo le imponenti e numerose manifestazioni di protesta, era arrivato l’apparente ritiro della proposta da parte del governo locale, salvo rispuntare direttamente a Pechino nei giorni scorsi. E’ un affronto al mondo, un modo per rivendicare la propria potenza su quella che sembrava essere un’eccezione di libertà in uno stato dittatoriale.
Le proteste di Hong Kong originano dalla crisi immobiliare e le soluzioni sono difficili
Non ci si aspetta grossi stravolgimenti da un giorno all’altro. L’assoggettamento di Hong Kong alla Cina avverrà gradualmente, entro 5 o 10 anni, ma la direzione sembra quella. Che ne sarà del suo status finanziario? Difficile pensare che le migliaia di società straniere quotate continueranno a restare, così come che la miriade di banche, assicurazioni e fondi d’investimento accetti supinamente di finire nelle mani di Pechino, anche perché nell’area esiste un altro hub finanziario molto simile a Hong Kong e che, a differenza di quest’ultimo, non presenta le sue incertezze politiche: Singapore.
Qui, però, saremmo di fronte a un mutamento non soltanto finanziario in senso stretto. I commerci tra Hong Kong e gli USA, ad esempio, rischiano di essere assimilati d’ora in poi a quelli sino-americani, cioè assoggettati agli stessi dazi e alle stesse restrizioni introdotte negli ultimi tempi. E lo stesso varrebbe pian piano per quelli con il Regno Unito, l’Australia, il Canada, il Giappone e la UE. Quella ricchezza guadagnata grazie alla libertà di questi decenni verrebbe gradualmente intaccata, si sgretolerebbe per tendere sempre più agli standard cinesi. E il prevedibile enorme deflusso dei capitali a cui assisteremmo nei prossimi mesi minaccerebbe lo storico “peg” tra dollaro locale e quello americano, fissato a 7,80 sin dal 1983. Anch’esso ha garantito solidità finanziaria allo stato autonomo. Tutto questo starebbe per finire. Una storia di grande successo e che la Cina ha finora potuto rivendicare con orgoglio sta per cedere il passo a una grande rovina.