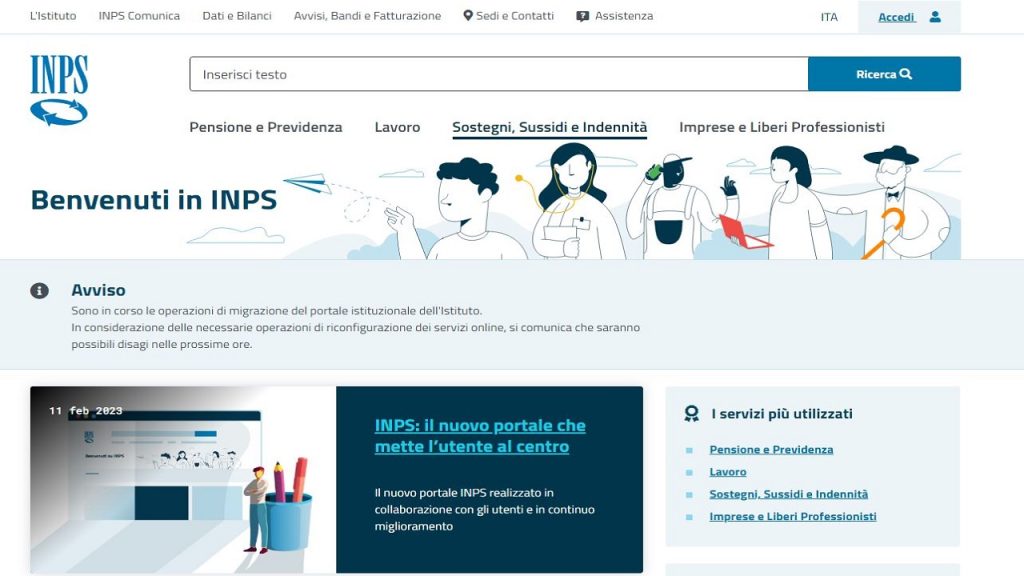La paura per l’inflazione non esiste più da tempo presso le economie mature. Bisogna essere almeno persone di mezza età per ricordarsi i tempi in cui in Italia i prezzi al consumo salivano a doppia cifra e il valore degli stipendi diminuiva drasticamente di anno in anno. Ora che l’inflazione non c’è, tutti la vogliono. Eppure, bisogna avere timore di ciò a cui si anela, perché se non si riesce a controllare l’oggetto dei propri desideri sono guai.
L’inflazione è per definizione la perdita del valore di acquisto della moneta. I prezzi salgono e per comprare lo stesso paniere di beni e servizi occorrono più soldi. Ad esempio, se i prezzi crescono mediamente del 5% all’anno per 10 anni, nel 2030 una banconota da 100 euro varrà il 63% in meno di oggi, cioè corrisponderebbe agli attuali 37 euro.
Non tutti soffrono per l’inflazione. I debitori e le imprese, generalmente, ne escono vincitori. I primi restituiranno ai creditori una quantità di moneta dal valore reale inferiore; le seconde tendono a tenere il passo con i prezzi, non fosse altro perché esse stesse li fissano. A rimetterci, i titolari dei redditi fissi: lavoratori dipendenti e pensionati.
Ora, qualcuno eccepirà che se gli stipendi vengono adeguati all’inflazione, alla fine i lavoratori non ci perderanno. Ma dal momento che i prezzi salgono a quando le retribuzioni verrebbero ritoccate al rialzo trascorre tipicamente un periodo di tempo non breve, anche perché i salari sono rinegoziati all’interno di complessi meccanismi contrattuali, per cui potrebbero occorrere finanche anni per vedere recuperato il potere di acquisto.
E se fossero proprio i bassi tassi a tenere l’inflazione a zero?
Gli effetti negativi dell’inflazione
Nel frattempo, i salari reali risulteranno più bassi e attireranno meno lavoratori sul mercato.
Molti, cioè, rinunceranno a lavorare ai salari dati, l’occupazione diminuirà e per evitare simili conseguenze, i governi faranno pressione sulle rispettive banche centrali, affinché illudano nuovamente il mercato con un’altra “sorpresa inflazionistica”, fingendo di centrare un tasso d’inflazione più basso di quello effettivo. Ancora una volta i lavoratori verrebbero fregati, i loro stipendi si contrarrebbero e l’occupazione verrebbe salvaguardata al costo di prezzi sempre più alti, dando vita a una spirale che per essere spezzata dovrebbe necessariamente passare per una fase di recessione economica.
Si consideri un altro aspetto. I lavoratori, più avversi al rischio, tendono a impiegare i propri risparmi nelle passività altrui, vale a dire acquistando perlopiù obbligazioni societarie e titoli di stato, i cui rendimenti reali si riducono con l’inflazione, potendo anche diventare negativi. E anche volendo disinvestire prima delle scadenze, i prezzi rischiano di risultare inferiori a quelli di acquisto, perché il mercato pretenderà rendimenti più alti (quotazioni più basse) per investirvi. Viceversa, i detentori dei grossi capitali puntano sull’equity, che nei periodi di reflazione tende ad esibire performance positive.
In definitiva, le distanze tra categorie sociali crescerebbero per il solo effetto dell’inflazione, non già per merito di alcune a discapito di altre. I manager, ad esempio, beneficiano generalmente di un piano retributivo, di cui una componente finanche elevata è variabile, legata alla performance delle azioni delle stesse società da loro guidate.
In uno scenario di inflazione in crescita, vedrebbero verosimilmente migliorare la loro posizione economica, ampliando le distanze con i dipendenti, i cui redditi reali diminuirebbero non solo per il contraccolpo accusato dagli stipendi, ma anche per il tendenziale deprezzamento degli investimenti. Siete sicuri di volere ancora inflazione?
Investire ai tempi della reflazione, cosa ci aspetta nei prossimi mesi
giuseppe.timpone@investireoggi.it