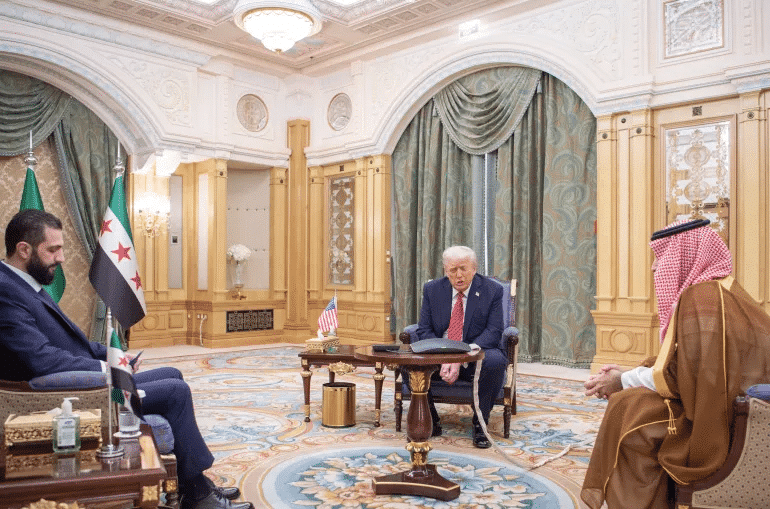Il regime “chavista” di Nicolas Maduro sarebbe agli sgoccioli, dopo che il presidente dell’Assemblea Nazionale, Juan Guaido, si è auto-proclamato presidente del Venezuela ed è stato subito riconosciuto da buona parte della comunità internazionale, a partire dalla Casa Bianca. Tuttavia, il dittatore non vuole sentire di lasciare il potere e ha invitato il personale diplomatico americano a lasciare il paese entro oggi, anche se il presidente Donald Trump ha confermato che i suoi funzionari resteranno a Caracas, non riconoscendo più l’autorità di Maduro di emanare ordini. Se questi dovesse cercare di resistere ad oltranza, come del resto fa già da anni in pieno collasso economico e isolamento quasi totale dal resto del mondo, Washington prenderebbe in considerazione stavolta seriamente di comminare dure sanzioni allo stato andino, colpendo le sue esportazioni di petrolio.
Sarebbe un disastro immane per un’economia già stremata dal crollo del pil e dall’iperinflazione, nonché con 3 milioni di persone che hanno lasciato il paese dal 2013 e altri 8 che avrebbero intenzione di farlo per la fame dilagante.
L’agonia del Venezuela, ecco come si è arrivati alla peggiore tragedia umanitaria in era moderna
L’embargo infliggerebbe danni anche agli stessi USA, con le sue raffinerie nel Golfo del Messico a dovere acquistare da altri paesi il greggio pesante di cui avrebbero bisogno per la produzione di derivati petroliferi, ma a costi verosimilmente maggiori. L’America ha acquistato nel 2018 la media di mezzo milione di barili al giorno dal Venezuela, pari al 39% del totale delle esportazioni petrolifere di Caracas, le quali costituiscono tra il 90% e il 95% del totale.
In buona sostanza, il regime di Maduro rischia più che mai di rimanere senza dollari, dato che la banca centrale detiene appena 8,8 miliardi di dollari come riserve valutarie, di cui si stima appena 1-1,5 miliardi realmente liquidi, il resto consisterebbe in oro.
Stando agli ultimi dati disponibili, ammesso che Caracas riuscisse a vendere tutto l’oro disponibile per ottenere la liquidità occorrente, le riserve basterebbero a coprire importazioni per appena 8-9 mesi prima di esaurirsi del tutto, in assenza di entrate nette dalle esportazioni. Una situazione insostenibile, che rischierebbe di provocare una crisi umanitaria ancora più disastrosa di quella in corso da un paio di anni almeno.
20 anni di disastro “chavista”
E dire che il Venezuela sarebbe la prima potenza petrolifera al mondo e ciò dovrebbe equivalere a ricchezza anche economica. Invece, la gestione clientelare e profondamente inefficiente delle risorse da parte del ventennio “chavista” ha trasformato l’oro nero in una condanna alla fame per 30 milioni di abitanti. Né si creda che la fine del regime, qualora avvenisse oggi stesso, possa portare un immediato sollievo alla popolazione. Il disastro è così immane, che nemmeno con gli aiuti internazionali sarà possibile eventualmente riparare in poco tempo. Purtroppo, ai venezuelani spetta un prossimo futuro ancora piuttosto tragico.
Partiamo dai numeri. Il Venezuela estrae il suo petrolio tramite la compagnia statale PDVSA. Era stata nazionalizzata prima ancora che al potere arrivasse Hugo Chavez nel 1999, segno che già prima dell’avvento del socialismo in salsa andina, l’economia stesse prendendo una brutta piega.
Il paese dispone di riserve petrolifere accertate per 300,9 miliardi di barili, superando persino i 266 miliardi dell’Arabia Saudita, che fino a non molti anni fa era prima al mondo. Nonostante ciò, Riad ha sfruttato il rialzo delle quotazioni dall’inizio del millennio fino al 2014, accumulando riserve valutarie fino a 740 miliardi di euro, vale a dire per un importo superiore al suo stesso pil e rivelatesi preziose per affrontare la crisi degli ultimi anni, avendo nel frattempo sostenuto il benessere della popolazione saudita. Viceversa, Caracas ha attinto ai petrodollari per fare spesa in deficit e sperperarle in clientele e inefficienze varie, ritrovandosi senza un centesimo al primo ripiegamento dei prezzi.
Venezuela, risalita del petrolio non aiuta: produzione in calo e vincolata ai debiti
Perché il petrolio non rende in Venezuela
Non solo. Mentre la saudita Aramco è considerata nel mondo un esempio di eccellenza nel panorama delle compagnie energetiche, tanto che il principe Mohammed bin Salman ha azzardato nel 2016 una sua capitalizzazione complessiva di 2.000 miliardi, la più alta al mondo per una società eventualmente che dovesse quotarsi in borsa, PDVSA è diventata l’emblema dell’inefficienza, della corruzione e dell’incompetenza del governo socialista al potere. Essa ha debiti per 34,6 miliardi di dollari, di cui 24,7 miliardi in obbligazioni. Su queste ultime, ha accumulato arretrati per quasi 8 miliardi nei pagamenti tra capitale e interessi, ovvero è formalmente in default dalla fine del 2017.
Per capire come sia stato possibile far fallire di fatto la gallina dalle uova d’oro del Venezuela, bisogna considerare che il costo di estrazione e vendita di un barile di petrolio per PDVSA ammonta ad appena 20 dollari, circa il doppio di quello sostenuto da Aramco e, in generale, dalle concorrenti nel Medio Oriente, ma intorno alla metà di quello delle compagnie USA. Considerando che un barile di Brent venga venduto in queste ultime sedute nei pressi dei 60 dollari, si direbbe che PDVSA goda di ampi margini di profitto. Falsissimo, perché non opera come una società privata, bensì come una mucca da spremere da parte del governo. Attenzione, perché ciò accade con la stessa Aramco, ma con una differenza enorme: la monarchia saudita non ha mai privato la compagnia delle risorse necessarie per investire, mentre Caracas ha sottratto alla propria fino all’ultimo centesimo ricavato, lasciandola senza capitali sufficienti per investire nelle trivellazioni di nuovi pozzi e nel mantenimento dei livelli estrattivi dei pozzi esistenti.
Non avendo risorse né da investire e né da garantire alle società partner nelle estrazioni, come l’italiana ENI fino a poco tempo fa, la produzione non ha fatto che diminuire, specie sotto la gestione sempre più politicizzata e militarizzata dei dirigenti nominati dal regime, scendendo alla media di 1,5 milioni di barili al giorno nel 2018, la più bassa da 30 anni. Era a 3,4 milioni all’arrivo di Chavez al potere e con un terzo dei dipendenti di oggi. Questo significa una sola cosa: il Venezuela riesce a estrarre ormai su base annua appena lo 0,18% delle sue riserve petrolifere. Troppo poco, se si pensa che Exxon vanta tassi di estrazione intorno al 9% del totale disponibile. In pratica, la compagnia americana riuscirebbe a estrarre tutte le sue riserve in 11 anni, mentre PDVSA ci impiegherebbe oggi come oggi quasi 550 anni. E se fossero confermate le previsioni negative degli analisti, secondo cui la produzione giornaliera quest’anno scenderebbe ad appena 900.000 barili, di anni per esaurire le riserve ce ne vorrebbero oltre 1.000. A titolo di confronto, Aramco sfrutterebbe le proprie in meno di 70 anni, mostrando un tasso di estrazione dell’1,44%, quasi 8 volte superiore a quello venezuelano.
Venezuela, petrolio gestito da un militare e default un’arma contro Trump
Petrolio asset svalutato in Venezuela
Come dire di possedere tanta roba, ma di non essere capace di venderla. Sul piano prettamente finanziario, applicando un tasso di sconto minimo al valore della produzione futura (una cosa è incassare 50-60 dollari al barile oggi, un’altra tra 10, 20 o 50 anni), si ottiene che il valore delle riserve venezuelane crollerebbe sostanzialmente a zero. Non così avverrebbe per quelle delle altre compagnie private o anche statali, come Aramco. A titolo di esempio, al tasso di sconto del 3%, presupponendo quotazioni stabili a 60 dollari, l’ultimo barile estratto dai sauditi tra quasi 70 anni varrebbe oggi 6,4 dollari, mentre l’ultimo estratto dal Venezuela tra oltre mezzo secolo zero. Naturale che nemmeno nel caso ipotizzato di cambio di regime e privatizzazione parziale della compagnia, il mercato assegnerebbe il giusto valore al petrolio di Caracas, perché per renderlo economicamente profittevole servirebbero capitali freschi da investire al fine di potenziarne le estrazioni giornaliere e il totale sganciamento dalla dipendenza dello stato. In effetti, non solo il petrolio è praticamente l’unico bene che il paese esporta, ma esso serve ad alimentare le casse statali, le quali per essere tenute in pareggio necessitano quotazioni sui 120 dollari al barile. In altre parole, già oggi, pur essendo ogni centesimo fatturato incassato dal governo, lo stato venezuelano non riesce nemmeno lontanamente a coprire la spesa pubblica, avendo bisogno di quotazioni doppie a quelle di mercato e pari a 100 dollari in più rispetto a quelle strettamente necessarie per coprire i costi di estrazione.
Da qui, la più che probabile depressione delle valutazioni nel caso in cui un eventuale governo d’impronta liberale decidesse di privatizzare parzialmente la compagnia. Fino a quando lo stato restasse azionista anche di minoranza, infatti, troppo alto sarebbe il rischio percepito che continui a spolpare PDVSA per la sua scriteriata politica fiscale. E così, se Exxon oggi capitalizza a Wall Street sopra i 302 miliardi, vale a dire a 14,3 dollari per ciascun barile detenuto tra le riserve e a 22 volte l’utile annuo, non fantastichiamo nemmeno di valori simili per la compagnia venezuelana, che continuerebbe anche dopo la fine del regime ad essere considerata finanziariamente debole e un capitolo politicamente sensibile per essere valutata adeguatamente.
Crisi Venezuela, come un’economia ricca di petrolio ha collassato
giuseppe.timpone@investireoggi.it