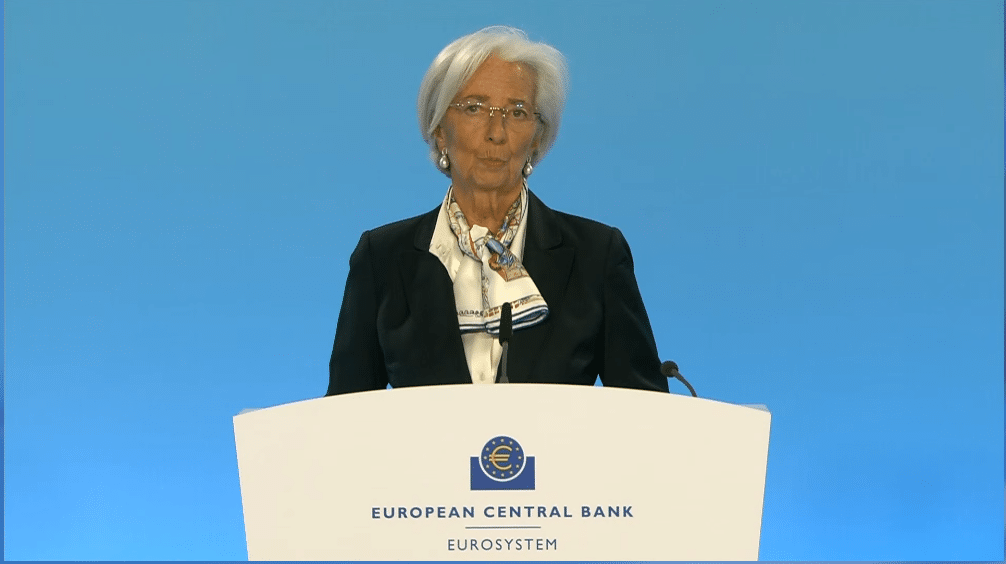Inaugurando la nuova Assemblea Nazionale, organismo non riconosciuto da gran parte della Comunità internazionale, il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato che per i cittadini sarà possibile d’ora in avanti pagare con le carte bancomat collegate ai conti correnti accesi in dollari. Secondo il governo, i due terzi degli scambi nel paese avvengono in bolivares, la valuta locale, ma gli analisti indipendenti trovano da tempo che la percentuale sia esattamente ribaltata: due pagamenti su tre avvengono in dollari americani.
L’economia venezuelana si sta gradualmente dollarizzando, pur in maniera spontanea e non per decisione istituzionale. Del resto, dopo anni di iper-inflazione, anche per pagare un caffè bisogna portarsi dietro zaini pieni di banconote. E dire che nell’agosto del 2018 siano stati tolte loro cinque zeri, passando al “bolivar soberano”.
Una situazione analoga si respira nel Libano, dove l’economia nell’ultimo anno è letteralmente collassata e i prezzi sono esplosi con il crollo della lira locale sul mercato nero. Ufficialmente, Beirut tiene ancorato il cambio al dollaro a poco più di 1.510 lire. Per strada, un dollaro si acquista ormai per oltre 8.000 lire, il doppio di quanto le banche scambino i loro depositi in valuta americana contro quella domestica.
La Banca del Libano blocca gli aiuti esteri e aggrava il collasso dell’economia
Ci sono stati paesi, però, che hanno dollarizzato le loro economie in maniera formale. In America Latina, l’esempio storicamente più rilevante si è avuto nel 1991 con la Ley de convertibilidad del 1991. Un peso veniva equiparato a un dollaro, sebbene tutti sapessero che così non fosse nella vita reale. Anche in quel caso, l’obiettivo consistette nel contenere l’inflazione e attirare capitali esteri. Non funzionò. Dopo un decennio, Buenos Aires dovette prima porre fine alla parità e subito dopo dichiarare default. Il cambio collassò all’istante dei due terzi.
Oggi, a distanza di neanche 20 anni, per un dollaro bisogna sborsare 87 pesos secondo il cambio formale e quasi 160 sul mercato nero.
Dall’Africa all’America Latina, flop dollarizzazione
Di recente, un’altra economia saltata in aria per effetto della dollarizzazione è stato lo Zimbabwe. Nel 2008, il paese precipitò nell’iper-inflazione, cessata la quale il governo decise di abbandonare la moneta nazionale per adottare un insieme di valute straniere per gli scambi interni e con l’estero. Il dollaro predominò, affiancato alla lontana da rand sudafricano, euro, yen, sterlina, etc. Ma la divisa americana si rivelò troppo forte per competere sui mercati esteri, ragione per cui scarseggiava, spingendo nel 2016 l’allora presidente Robert Mugabe ad emettere titoli di credito denominati in valuta locale e nel rapporto di 1:1 contro il dollaro USA, un modo per camuffare agli occhi dei cittadini il ritorno all’emissione di moneta sovrana.
Attualmente, ci sono tre stati sudamericani che adottano il dollaro come moneta propria: El Salvador, Panama ed Ecuador. I risultati sono stati per tutti e tre negativi. Tutti esibiscono saldi commerciali cronicamente negativi, segno che non riescano ad esportare a sufficienza. E persino le partite correnti sono in rosso, smentendo le previsioni di un afflusso dei capitali tali da eventualmente compensare i deficit commerciali.
L’Ecuador nel 2020 ha dovuto ristrutturare il suo debito sovrano. Il precedente default risaliva solamente al 2008, 5 anni dopo l’avvio della dollarizzazione.
Perché per il Venezuela dovrebbe essere diverso? A dire il vero, la stessa Caracas è rimasta vittima della sua dollarizzazione perseguita sotto Hugo Chavez sin da inizio millennio e procrastinata fino a qualche anno fa dal successore Maduro. Il primo volle così arrestare la fuga dei capitali e con il boom delle quotazioni petrolifere, per circa un decennio il sistema monetario resse. Ma quando nel 2014 il greggio iniziò a scendere di prezzo sui mercati, il bolivar al mercato nero implodeva, arrivando a scambiare decine di migliaia di volte più debolmente rispetto al cambio ufficiale, che dovette essere abbandonato per via delle riserve valutarie prosciugate, che a loro volta provocarono il crollo delle importazioni e dell’offerta di beni e servizi interni.
Bond Venezuela, ecco l’offerta di aiuto agli obbligazionisti italiani
I limiti della dollarizzazione
Perché la dollarizzazione alla lunga non funziona mai? Essa viene adottata da economie alle prese con problemi strutturali di crescita e inflazione e come palliativo per non implementare le riforme necessarie all’economia nel medio-lungo periodo. Sono poco competitive e prive di stabilità dei prezzi, per questo non riescono neppure ad attirare capitali. Inizialmente, fissando la parità con il dollaro o adottando direttamente quest’ultimo come unica moneta nazionale, il mercato concede un minimo di credito, anche perché l’inflazione rientra e il potere di acquisto si mantiene stabile. Ma di fatti, si finisce per esporsi alla politica monetaria e alla congiuntura degli USA, i cui cicli possono coincidere solo per caso con quelli delle suddette economie. Con il tempo, la moneta forte incentiva le importazioni e colpisce le esportazioni. Gli investitori non si fidano più e temono la svalutazione man mano che le riserve valutarie si assottigliano. La profezia si auto-avvera e il governo è costretto sia a svalutare il cambio (o a tornare a battere moneta propria), sia a dichiarare default, non riuscendo più a pagare il debito contratto in valuta forte.
In teoria, il Venezuela ricco di riserve petrolifere avrebbe la possibilità di imitare l’Arabia Saudita, che ha fissato un “peg” contro il dollaro sin dal 1985 e oggi si ritrova con l’ottavo fondo sovrano più grande al mondo (400 miliardi di dollari) e riserve valutarie per oltre 455 miliardi di dollari, pari ai due terzi del PIL.
Ma c’è una differenza di fondo tra Caracas e Riad: la prima non è stata capace di accrescere la produzione neppure negli anni d’oro delle quotazioni a tre cifre, la seconda è il primo esportatore di greggio al mondo e produce per pochi dollari al barile di costo. E ancora: il Venezuela non attira capitali, in quanto economia socialista e gestita con criteri clientelari ed opachi, mentre il regno ha utilizzato gli immensi proventi petroliferi per accrescere realmente il benessere della popolazione, pur patendo oggi di bassa occupazione. La dollarizzazione venezuelana non ha retto per il semplice fatto che aveva reso il cambio fortissimo, disincentivando le produzioni locali. Per il paese andino significherebbe pensare di risolvere il problema ripristinandone le cause e sfuggire da politiche monetarie e fiscali solide.
Il crollo della lira egiziana è una dura lezione sui cambi fissi
giuseppe.timpone@investireoggi.it