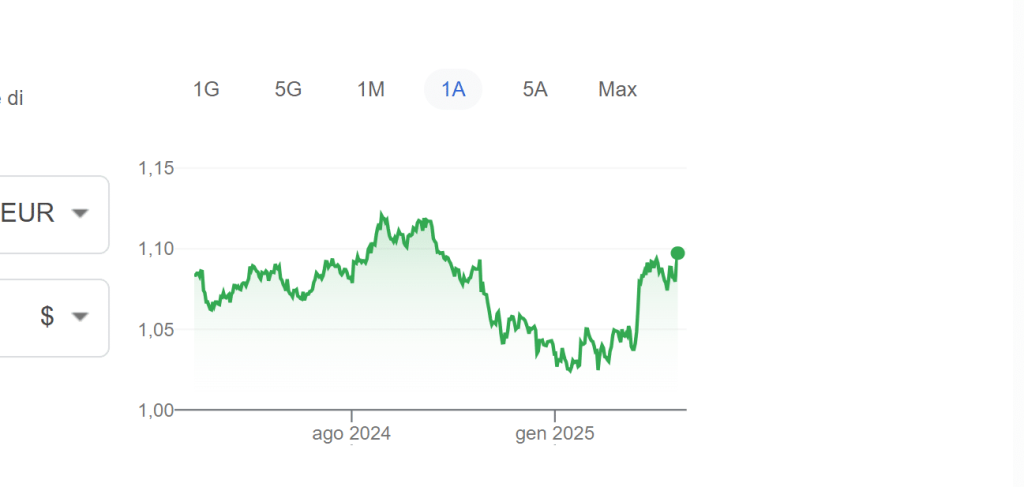Il vice-premier Luigi Di Maio ha annunciato nei giorni scorsi che il governo giallo-verde lavorerà a una riforma bancaria nei prossimi mesi. In cosa consisterà? Nell’introduzione in Italia della “Glass-Steagall Act”, oltre che alla creazione di un fondo di garanzia del risparmio, alimentato dal 60% dei bonus dei manager e per cinque anni. Obiettivo: separare le banche commerciali dalle banche d’affari. Non serviva forse arrivare a scomodare la legislazione americana degli anni Trenta, smontata negli USA alla fine degli anni Novanta sotto la presidenza Clinton, dato che l’Italia varava con la legge bancaria del 1936 una riforma assai simile a quella voluta dal presidente Franklin Delano Roosevelt e soppiantata solo nel 1993 dalla riforma Amato.
Banche di credito cooperativo, riforma Renzi azzerata? Salvini guarda al “sovranismo” tedesco
In cosa consisteva la legge scritta sotto il fascismo? Sostanzialmente, nella separazione tra banche commerciali e istituti di credito, con le prime titolate a raccogliere e prestare denaro a medio-breve termine e i secondi a raccoglierlo e prestarlo a medio-lungo termine. L’obiettivo fu sin dall’inizio chiaro: evitare il sorgere di una nuova crisi bancaria, come quella che agli inizi degli anni Trenta aveva sconquassato il nostro sistema del credito, a causa della forte commistione proprietaria con le imprese clienti e la cattiva gestione della liquidità, con risparmi raccolti a breve e spesso prestati a lungo.
Quando l’Italia, a seguito dell’adozione dell’Atto Unico Europeo del 1986, aprì il suo sistema bancario, il panorama creditizio nazionale apparve subito desolante al confronto con le realtà straniere. Esso risultò affollato di tanti piccoli nani, incapaci di finanziare adeguatamente le imprese, a causa delle criticità legate proprio alla raccolta del risparmio. In pratica, c’erano tantissime piccole banche commerciali (106 quelle ordinarie al 1990) che prestavano denaro a imprese e famiglie, ma disponendo di risorse inadeguate, non riuscivano a soddisfare la domanda.
Dall’altra parte, vi erano pochi istituti di credito (6), poco radicati sul territorio e che possedevano somme più ingenti da erogare, le quali non riuscivano, però, a fluire del tutto all’economia reale. Insomma, la stabilità era stata centrata, ma a discapito dell’efficienza.
I tentativi di controriforma con la crisi del 2008
Per questo, sotto la tanto vituperata gestione del governatore Antonio Fazio (1993-2005), la Banca d’Italia agì per consolidare il panorama bancario, favorendo aggregazioni tra ex banche commerciali e istituti di credito. Le prime portavano in dote una rete di filiali sparse su tutto il territorio nazionale, i secondi i capitali. E così, nacquero colossi come Sanpaolo-IMI, una delle più fortunate e rinomate tra le 147 fusioni avvenute solo tra il 1998 e il 2002. Il timore di Palazzo Koch, rivelatosi più che fondato, era che le nostre banche risultassero piccole e poco attrezzate per resistere alla tentazione dei grandi gruppi stranieri, specie tedeschi, francesi e olandesi, di scendere nello Stivale a fare campagna acquisti di istituti relativamente piccoli, ma in possesso dei lauti risparmi degli italiani. Quel denaro – il timore – sarebbe finito per finanziare perlopiù le imprese straniere, privando le nostre ancora di più del credito necessario per operare e crescere.
La crisi finanziaria del 2008, esplosa negli USA, viene spesso addebitata proprio alla liberalizzazione che nemmeno un decennio prima aveva riguardato le banche americane, similmente a quelle italiane. La presidenza Obama introdusse così limitazioni stringenti all’operatività degli istituti, come la cosiddetta “Volcker rule”, dal nome dell’ex governatore della Federal Reserve, Paul Volcker, in base alla quale alle banche è fatto divieto di utilizzare i risparmi raccolti tra la clientela e garantiti per scopi di trading proprietario o per investimenti in “hedge fund”, in quanto considerati ad alto rischio. Di recente, l’amministrazione Trump ha segnalato l’intenzione di rendere tali vincoli meno soffocanti, sebbene abbia al contempo segnalato l’intenzione di tornare alla distinzione degli anni Trenta.
Grandi banche al capolinea? L’America di Trump ripensa agli anni Trenta
La soluzione sbagliata del governo
Ora, ammesso che l’origine della crisi del 2008 fosse riconducibile alla liberalizzazione di fine anni Novanta, l’Italia che ci azzecca, per dirla con l’espressione tipica di un famoso magistrato prestatosi alla politica? Le banche italiane di tutto possono essere accusate, tranne che di essersi buttate nella finanza speculativa in misura tale da creare rischi sistemici. Al contrario, sono state le uniche per anni a non avere richiesto alcun aiuto pubblico, nonostante nel resto d’Europa s’impiegarono fino a 3.000 miliardi di euro dei contribuenti per garantire i vari sistemi bancari prossimi al collasso. I nostri problemi iniziarono, invece, anni dopo, quando l’incapacità dell’economia italiana di superare gli effetti della crisi sfociò nell’aumento esplosivo dei crediti deteriorati (NPL), colpendo i bilanci degli istituti.
Di Maio paventa la soluzione sbagliata a un problema serio, ma che ha altre radici. Le banche italiane non sono complessivamente in crisi per via dell’azzardo finanziario, quanto per i guai dell’economia. Servirebbe far ripartire quest’ultima, nel frattempo favorendo sul piano legislativo l’adozione di strumenti concreti per velocizzare l’abbattimento degli NPL e l’integrazione tra realtà complementari, così da potenziarne la solidità patrimoniale. Vero, poi, che cattive pratiche sui prestiti siano state una concausa forte degli sconquassi recenti, come nel caso di MPS e delle sei minori salvate dallo stato tra la fine del 2015 e l’inizio del 2017 (Banca Marche, Banca Etruria, Carife, CariChieti, Popolare di Vicenza e Veneto Banca), ma esse hanno avuto origine sia nel capitalismo relazionale tipico del nostro Paese, sia nella longa manus della politica, attraverso le Fondazioni, un retaggio maledetto ereditato dalla Prima Repubblica e transitato attraverso la soluzione legislativa voluta dalla riforma del 1993, che ha consentito ai partiti di continuare a detenere il controllo di varie realtà radicate sui territori.
Banche italiane, l’ennesimo salvataggio pubblico è spia di un sistema malato e incartato
I rischi di una controriforma italiana
Separando banche commerciali da banche d’affari, corriamo il rischio di tornare a oltre un quarto di secolo fa, quando avevamo istituti di credito troppo piccoli per sostenere l’economia e per resistere alle scorrerie straniere. I colossi francesi e tedeschi, ad esempio, farebbero di essi un solo boccone e con poche operazioni e capitali limitati s’impossesserebbero di gran parte del mercato del credito nazionale. E c’è un altro problema poco studiato: la separazione contabile degli assets. Le banche italiane posseggono oggi qualcosa come oltre 380 miliardi di euro di titoli di stato tricolori, di cui al 30 giugno scorso più di 66 miliardi in capo a Unicredit, 47 a Intesa-Sanpaolo, 25 a MPS, 20,5 a BPM. A chi resterebbero in pancia e con quali effetti? I BTp valgono attualmente più di un decimo dei patrimoni bancari italiani, una percentuale già ritenuta molto alta negli ambienti della Vigilanza europea, in quanto esporrebbe gli istituti ai rischi sovrani.
Va da sé che nel caso di separazione, questi assets peserebbero per una percentuale spropositata dei patrimoni delle banche commerciali o di quelle d’affari a cui verrebbero appioppati, costringendole verosimilmente a venderne una parte consistente per rassicurare Francoforte da un lato e per allentare l’eccessiva esposizione alla volatilità dei bond dall’altra. Sarebbe un disastro per il Tesoro, costretto a trovare nell’immediato domanda sostitutiva con tanto di aggravio dei costi per rifinanziarsi sui mercati, ma anche per le stesse banche, le quali possono accedere ai prestiti agevolati della BCE esibendo questi titoli come collaterale di garanzia. Altra cosa sarebbe, invece, pretendere che sul piano contabile si operi una distinzione tra gestione finanziaria e speculativa da un lato e quella più propriamente commerciale dall’altra, senza per ciò stesso recidere i due comparti, che appaiono spesso beneficamente complementari, allorquando le criticità dell’uno vengono attutite o finanche superate dalle opportunità dell’altro e viceversa. L’Italia non ha bisogno di tornare al passato, anche perché di fasti da raccontare ve ne sono davvero pochi. In fondo, le famiglie hanno iniziato a ricevere mutui in misura soddisfacente e a costi contenuti solo dalla metà degli anni Novanta, in coincidenza proprio con la liberalizzazione bancaria, oltre che con la marcia di avvicinamento all’euro. Fino ad allora, si comprava casa perlopiù in contanti, roba che oggi si permetterebbero davvero in pochi.
Le banche italiane ci salveranno dallo spread, facendosi un favore
giuseppe.timpone@investireoggi.it