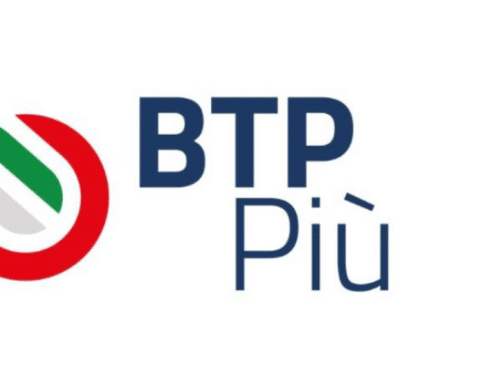Uber e Airbnb sono solo i due esempi più famosi di sharing economy: un concetto che racchiude tante altre piattaforme di condivisione. La disputa sui cambiamenti introdotti da questo sistema è aperta, non solo a livello fiscale. In questa sede non ci chiediamo se i tassisti di Uber dovrebbero avere la licenza o se gli host di Airbnb dovrebbero essere considerati a tutti gli effetti albergatori ma in che modo queste piattaforme abbiano cambiato il mondo del lavoro. Che vi siano utenti che con quest’attività si sostentano è ormai indubbio e questo accade in tutto il mondo.
Sono da considerarsi lavori? Queste start up miliardarie (anzi più propriamente come si legge online “startup che sono state in grado di trasformare le idee in miliardi”), sostenitrici della sharing economy, per alcuni sono un modo per integrare lo stipendio, per altri rappresentano il salario primario che spesso fugge ai controlli del Fisco ma che non offre neppure garanzie. Non parliamo solo di ferie, congedi, malattie etc: al driver di Uber basta non ottenere cinque stelline per essere penalizzato nei guadagni. Negli Stati Uniti il Gao (Government Accountability Office), ha approfondito il mondo di questi nuovi lavoratori a termine che popolano la gig economy. Ma su questo fronte l’analisi più approfondita, e per certi versi impietosa, è quella effettuata dal Wall Strett Journal che ha parlato di “nuovo feudalesimo e di servi della gleba”. La giornalista Emily Guendelsberger qualche mese fa ha svolto un’inchiesta tra i driver di Uber a Philadelphia per verificare i veri guadagni e sembra proprio che non è tutto oro quello che luccica.
Eppure molti, che “investono” la macchina o la casa in piattaforme come Uber o Aibnb, fanno confusione e smettono di cercare altrove con il rischio di trovarsi senza entrate (senza lavoro lo sono già) qualora questo castello, ovvero questa sorta di paradiso fiscale online, crolli come sta accadendo dopo la <a